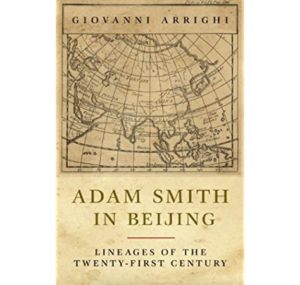Alcuni anni fa l’economista e storico Giovanni Arrighi pubblicò un curioso testo dal titolo “Adam Smith a Pechino”, che raccolse l’interesse dei cultori della geopolitica. Arrighi, che ci ha lasciato nel 2009, aveva un percorso professionale davvero singolare, alla sua morte aveva una cattedra di sociologia alla John Hopkins University a Baltimora, si era formato alla Bocconi di Milano, aveva insegnato in Africa prima di trasferirsi negli Stati Uniti negli anni settanta.
Arrighi era un marxista legato ai precetti dell’ortodossia, potremmo chiamarlo un intellettuale organico, capace di farsi contaminare da altri pensatori come Immanuel Wallerstein, il filosofo americano esperto di Africa a sua volta e debitore al pensiero di Marx e del concetto di conflitto ineludibile all’interno di una società.
Negli ultimi anni di vita, Arrighi ribadiva che l’occidente fosse in crisi, perlomeno da quando aveva sostituito la produzione ad una crescente finanziarizzazione dell’economia, per garantirsi maggiori di margini del profitto, lasciando le catena di produzione fisica del valore ai nuovi paesi emergenti.
Il pensiero di Arrighi trovava il coronamento della sua carriera nel libro “Adam Smith a Pechino”, dove affermava che in Cina si stava realizzando un’economia socialista di mercato in conformità a quanto dichiarato nello statuto del partito comunista cinese nel 1998.
Arrighi uomo estremamente colto, come sono i marxisti che vivono sulla costa est degli Stati Uniti, fece flirtare Adam Smith e Pechino in modo davvero originale. Il filosofo scozzese aveva scritto di Cina “Nelle ricerche sopra la natura e la causa della ricchezza delle nazioni” nel 1776, il trattato su come si dovrebbero comportare le nazioni per accrescere la propria ricchezza ed il proprio benessere. Per quanto i diaristi e viaggiatori del tempo descrivessero la Cina come paese miserabile ed i cinesi disposti a nutrirsi dei “più schifosi rifiuti gettati fuori bordo dalle navi europee”, Smith si convinse di altro, affermando che i prezzi dei cereali erano bassi, come il costo del lavoro ma alta la rendita fondiaria, tale da giustificare una certa staticità del modello, la poca industria e la ricerca di nuovi mercati.
Ciò che affascinava Smith era che la Cina fosse un mondo a sé, governato da un imperatore che non riconosceva libertà politiche e che non concedeva privilegi a compagnie, che agivano per l’accumulazione del denaro e privilegi in modo disordinato e selvaggio come in occidente. Ad un uomo di chiesa come Smith, legato all’idea dell’autorità e all’equilibrio armonico del sistema, la Cina piaceva molto, come pure ad Arrighi, che da marxista era fedele di un altro credo, fatto di in uno stato “etico”, dotato di una moralità superiore e capace di tenere a bada l’ingordigia dell’uomo.
Arrighi disprezzava il capitalismo, ma non il mercato e lo fa raccontare a Smith anche se era morto da secoli, sostenendo che il modello cinese sedava le spinte economiche che portano alla disoccupazione e minano la pace sociale diventando un regolatore degli eccessi dell’economia. La Cina di Arrighi, definiamola così, mette in competizione i capitalisti, annulla la pressione tra lavoro e capitale, stabilisce il limite del profitto per accrescere il proprio potere centrale.
Arrighi non annunciava un ventunesimo secolo cinese, anche se un nuovo modello, che definisce Beijing Consensus potrebbe affiancare e poi sostituire il riferimento americano, ma fa capire che ne avrebbe la forza attraverso l’acquisto del debito pubblico statunitense, la fornitura di beni di consumo, un approccio pragmatico alla crescita economica e la creazione di nuove forme di cooperazione con i paesi del sud del mondo. Infine, l’economista sosteneva che dopo gli incidenti di piazza Tienanmen si sarebbe trovato una sintesi tra liberismo borghese ed il comunismo per una giustizia sociale universale.
A distanza di più di dieci anni dall’uscita del libro di Arrighi possiamo affermare che le cose siano andate in maniera differente, in Cina rimangono sacche di povertà fatte da centinaia di milioni di persone, e pur formandosi un ceto medio di consumatori, nota bene consumatori e non cittadini, lo sfruttamento del lavoro non appare tanto differente dai peggiori modelli capitalistici, si pensi alla riduzione di quasi schiavitù di lavoratori destinati a morire perché chiusi a chiave in fabbriche prigione durante un incendio, sovente gli stessi partner occidentali delle joint venture, risultano impegnati a garantire il rispetto degli standard minimi di legge nei posti di lavoro.
Le vessazioni delle minoranze etniche tibetane, mongole e iugure sotto gli occhi del mondo e le recenti dichiarazione di Xi Jinping per l’omologazione definitiva di un modello han (l’etnia dominante) promettono anni di nuove violenze, oltre alle aspirazioni neo colonialiste in Africa in abiti diversi da quelli occidentali, come il progetto delle vie della seta e del cappio del debito, ma altrettanto abbiette.
Le analisi di Arrighi descrivono un mondo che non esiste più, l’ultima modernità pretende investimenti in ricerca e sviluppo crescenti – Schumpeter ipse dixit – ma lo stato cinese drenando i profitti, che sarebbero investimenti, sterilizza l’innovazione. La soluzione è stata la costruzione di un’economia che si fonda sulla predazione dell’ingegno altrui e sul mancato rispetto della proprietà dei diritti intellettuali e dei marchi, rendendo è il modello cinese intimamente parassitario, ma coerente con la visione tradizionale del confucianesimo, che non biasima la sottrazione della creatività altrui e non incoraggia l’ingegno individualistico o di una società privata (dicotomia numero – individuo).
Altro elemento critico di sistema è l’affermazione del “patriottismo d’impresa” prima del profitto. La cronaca di questi giorni racconta la presenza del presidente Xi Jinping all’inaugurazione di un museo dedicato a Zhang Jiang, un imprenditore che dal 1895 al 1925 fu il campione dell’imprenditoria Guandu Shangban, ovvero supervisionata dallo stato. L’Economist di questa settimana ci ha dedicato un bell’articolo “Patriotism before profit”, nel quale si ricorda la storia vera dell’imprenditore amato da Mao Zedong e Xi jinping, l’opaca gestione dell’amministrazione, la distrazione per uso personale dei capitali d’impresa, fino al salvataggio in extremis nel 1922 dal fallimento da parte di un consorzio di banche.
Se ancora si trovasse qualcuno che non è soddisfatto delle critiche al pensiero di Arrighi li legga quanto dichiarò in un’ultima intervista a David Harvey e pubblicata postuma e ci si chieda dove sia la Cina: “Identificare il socialismo con lo stato crea grossi problemi. Di conseguenza, se un sistema mondiale di questo tipo dovesse essere chiamato socialista, sarebbe il caso di ridefinirlo in termini di reciproco rispetto tra gli esseri umani e di rispetto collettivo per la natura. Ma lo si dovrebbe forse organizzare, però, attraverso scambi di mercato regolati dagli stati in modo tale da rafforzare i lavoratori e indebolire il capitale in termini smithiani”
Osserva lo storico Valerio Romitelli, dalle pagine web di Sinistra in rete, “Da quando, nei primi anni Ottanta del secolo scorso, Deng Xiaoping ha incominciato a teorizzare una via tutta cinese a un inedito «socialismo di mercato», la retorica del partito è divenuta infatti sempre più decisamente qualificabile come nazional-comunista. Nel senso che l’obiettivo del comunismo non è concepito altrimenti che come conseguenza dei successi nazionali. Come dire, una sorta di «China first!» come controcanto al trumpiano «America first!”.
L’errore di Arrighi è stato pensare la Cina con categorie occidentali, come tutti i figli di Hegel, che vedevano la fine della storia ed uno lieto fine.
3 dicembre